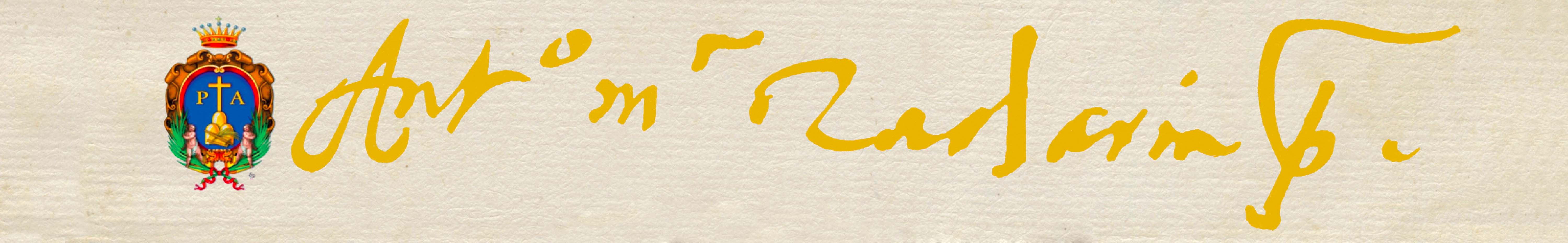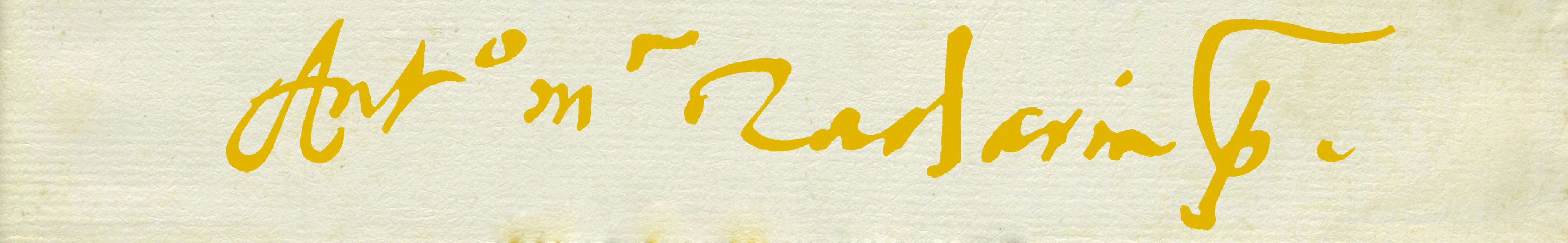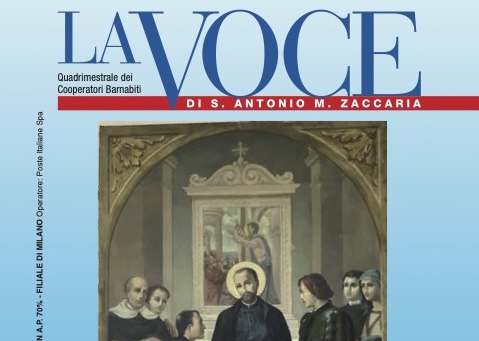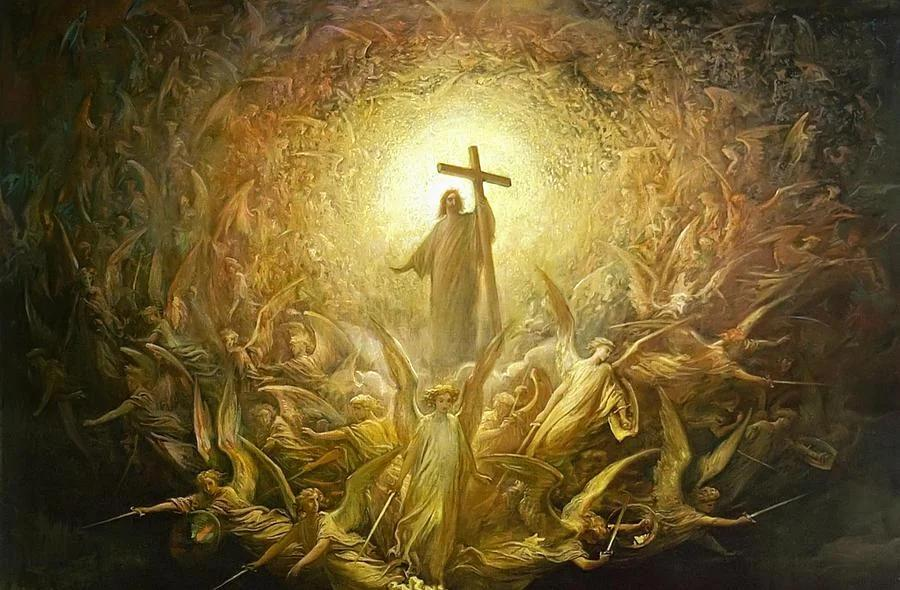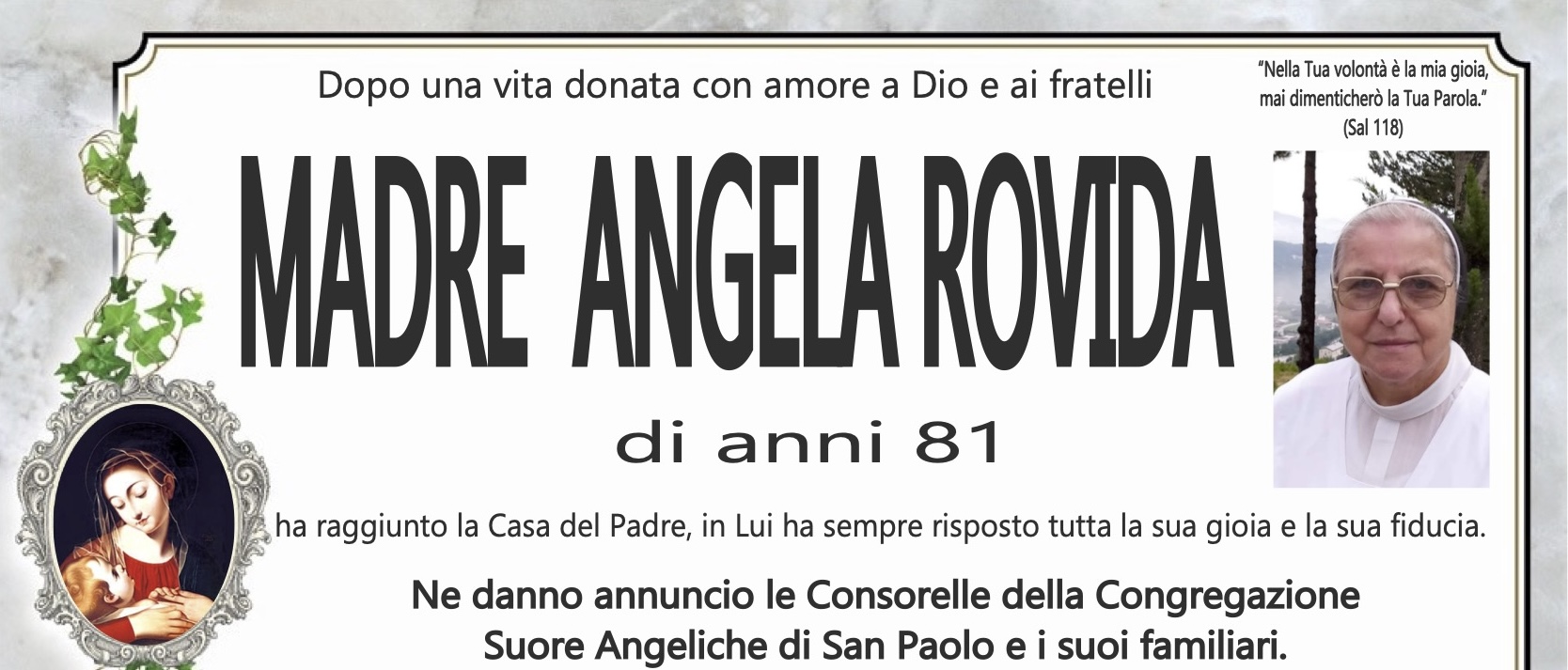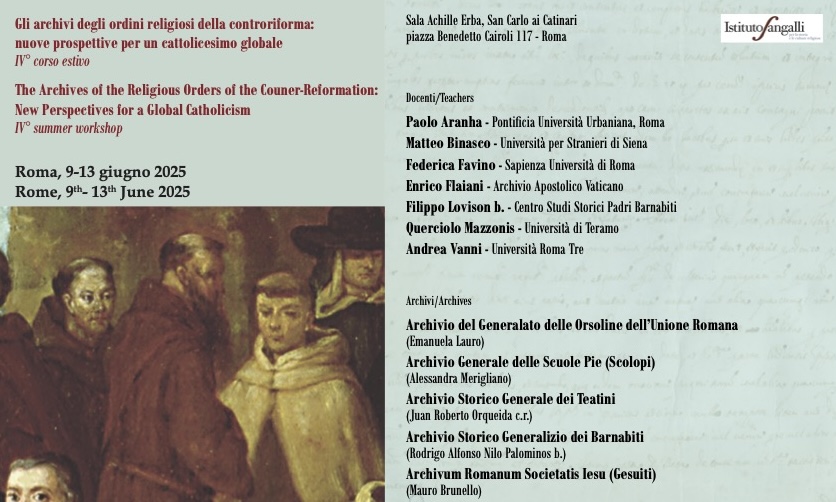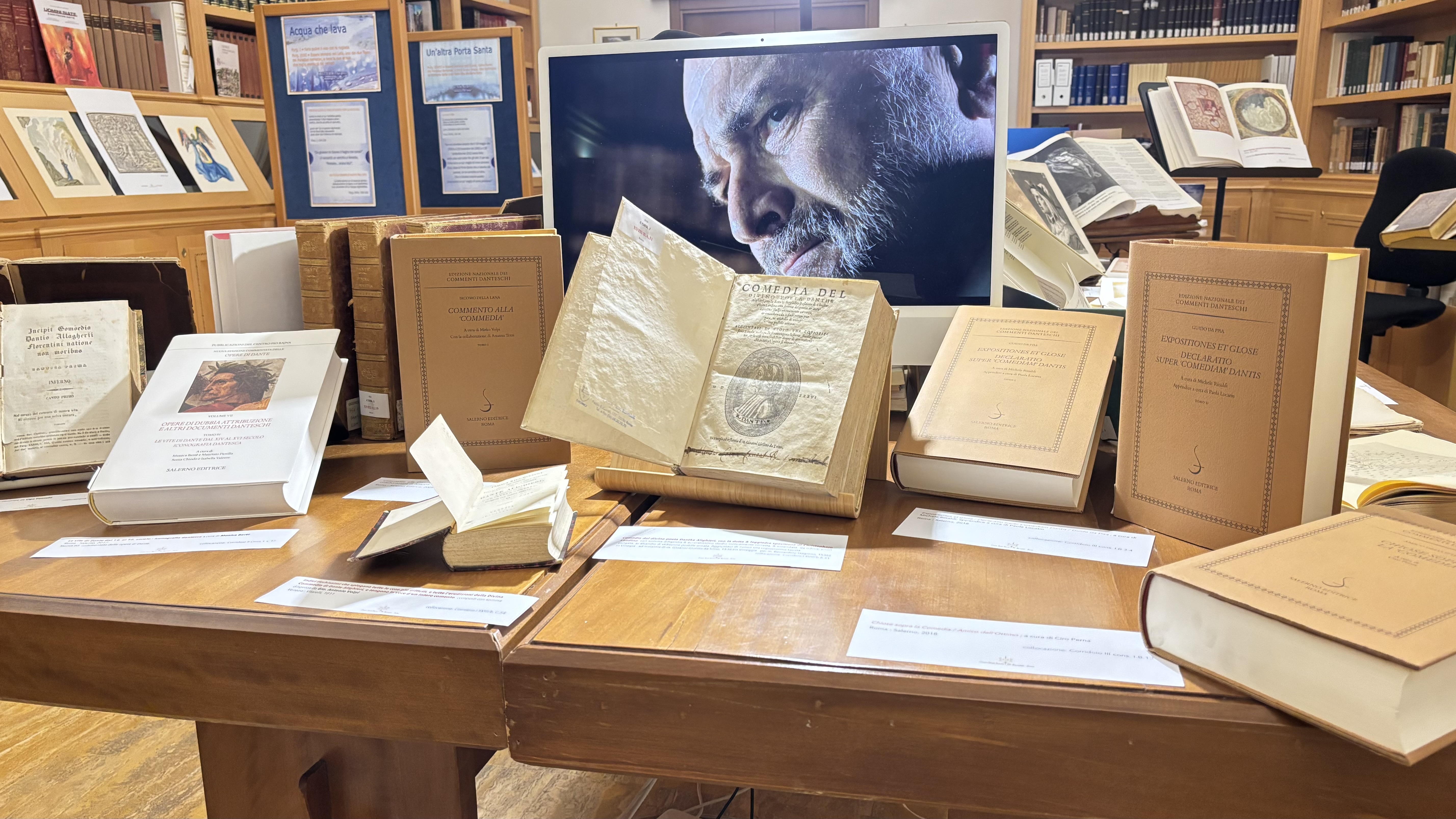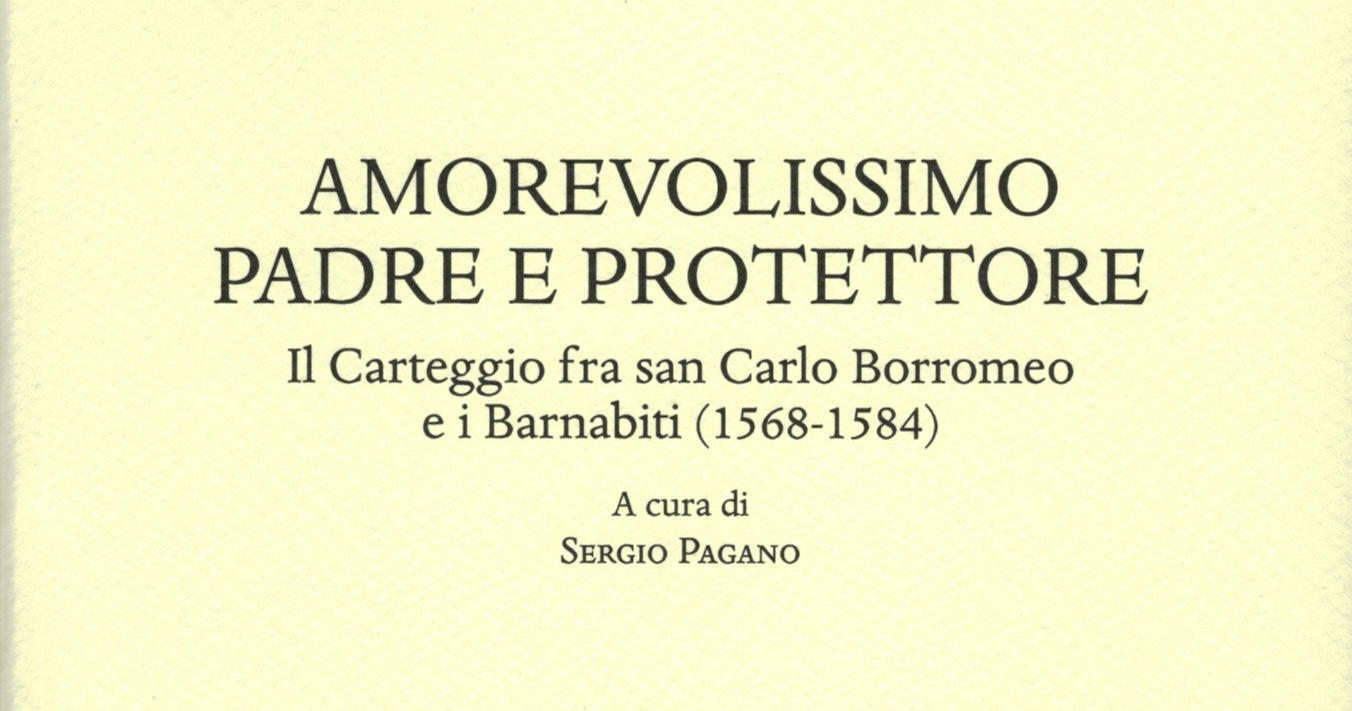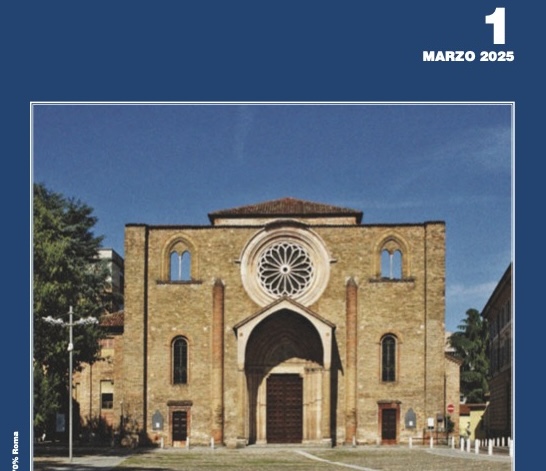L’omelia del Nunzio Apostolico S.E.Mons. Antonio Guido Filipazzi, pronunciata il 23 marzo durante la messa delle 12.30 nel santuario mariano di Jasna Góra
CAPITOLO GENERALE BARNABITI
(23 marzo 2025)
- Siamo raccolti attorno all’altare del Signore in questa casa della Vergine Maria, dove appare bene come Ella sempre guidi i fedeli all’Eucaristia (cfr. Giovanni Paolo II, Redemptoris Mater, 44), cioè alla duplice mensa della Parola e del Pane di vita eterna.
E oggi la liturgia della Parola ci ha anzitutto presentato la manifestazione di Dio a Mosè nel roveto ardente, come abbiamo ascoltato nella prima lettura. Di tale episodio biblico i Padri della Chiesa e la liturgia della Chiesa danno anche un’interpretazione mariana. Ad esempio, un’antifona liturgica dice: “Come il roveto che Mosè vide ardere intatto, integra è la tua verginità, Madre di Dio: noi ti lodiamo, tu prega per noi” (secondi vespri, Solennità di Maria Madre di Dio).
Anche noi siamo venuti qui a lodare la Madre di Dio e a chiedere l’intercessione di Lei per il Capitolo Generale della Congregazione dei Chierici Regolari di S. Paolo Apostolo. Ma dobbiamo anche metterci in ascolto di Lei, che, come ai servi delle nozze di Cana, sempre ci rivolge quelle che sono state le sue ultime parole riportate dai Vangeli: “Fate quello che vi dirà” (Gv 2, 5).
E che cosa ci dice oggi il Signore Gesù? Abbiamo appena ascoltato il brano del Vangelo di S. Luca, che contiene un’indicazione del Maestro su come leggere gli avvenimenti della vita, sempre “collocandoli nella prospettiva della conversione” (Benedetto XVI, Angelus, 7.3.2010) e, poi, la parabola del fico che non dà frutto. Ed è su quest’ultima che vorrei soffermarmi.
- Nella parabola possiamo considerare alcuni aspetti.
*) Anzitutto, vi sono i personaggi che agiscono: “Il padrone raffigura Dio Padre e il vignaiolo è immagine di Gesù” (Francesco, Angelus, 24.3.2019). Quindi, il Figlio di Dio “è simile a quel contadino che, con una pazienza senza limiti, ottiene ancora una proroga per il fico infecondo” (Angelus, 28.2.2016). Come afferma un Padre della Chiesa, Gesù è “il nostro avvocato presso il Padre, la nostra propiziazione, e il giardiniere delle sue anime” (S. Cirillo di Alessandria, Commento a Luca, omelia 96).
E il Santo Padre Francesco così ha commentato tale richiesta di proroga da parte del contadino: “Un “anno” di grazia: il tempo del ministero di Cristo, il tempo della Chiesa prima del suo ritorno glorioso, il tempo della nostra vita, scandito da un certo numero di Quaresime, che ci vengono offerte come occasioni di ravvedimento e di salvezza, il tempo di un Anno Giubilare… L’invincibile pazienza di Gesù! Avete pensato, voi, alla pazienza di Dio? Avete pensato anche alla sua irriducibile preoccupazione per i peccatori, come dovrebbero provocarci all’impazienza nei confronti di noi stessi?” (ibid.). E il vostro Capitolo Generale non fa anch’esso parte dell’anno di grazia che il Signore nella Sua pazienza concede come occasione “di ravvedimento e di salvezza”?
*) La scena della parabola ruota attorno al fico. Lungo i secoli sono state date diverse interpretazioni di esso; esse non si escludono, ma si completano vicendevolmente. Così, “l’albero in parola è il genere umano”, ci dice S. Agostino (Discorsi 254, 3). È anche il popolo di Israele o la città di Gerusalemme, che Gesù sta per visitare. Il fico rappresenta pure ciascuno di noi.
E alla luce di quanto leggiamo nel Concilio Vaticano II (“Come in un albero piantato da Dio e in un modo mirabile e molteplice ramificatosi nel campo del Signore, sono cresciute varie forme di vita solitaria o comune e varie Famiglie” (Lumen Gentium, 23), non possiamo vedere in esso anche la vita consacrata? Il fico non è anche la vostra Congregazione, albero ormai secolare e diffuso in varie parti del mondo?
*) Il padrone “venne a cercare frutti”. Con una interpretazione che forse ci lascia un po’ sconcertanti il mio patrono S. Antonio da Padova afferma che il “fico” è “così chiamato da “fecondità” (Sermone della II domenica dopo Pentecoste, 4). Ricordiamo che in un’altra pagina del Vangelo si parla di un fico, che il Signore Gesù, entrando in Gerusalemme, maledisse, perché “non vi trovò altro che foglie” (Mt 21, 18-19), cioè perché era infecondo.
Nel Nuovo Testamento i “frutti” sono le virtù che tutti i discepoli del Signore devono vivere. Questi “frutti” sono anche gli atteggiamenti propri delle diverse vocazioni, per cui vi sono dei “frutti” che devono portare i ministri ordinati o i fedeli laici o le persone consacrate.
- Tommaso d’Aquino afferma: “Si dicono religiosi per antonomasia coloro che si consacrano totalmente al divino servizio, offrendosi a Dio come in olocausto” (S. Th. II-II, 186, 1). E ha spiegato che “l’uomo è in possesso di tre beni… Dei beni esterni. E questi vengono offerti totalmente a Dio con la povertà volontaria… Dei beni del corpo. E questi vengono offerti a Dio specialmente con il voto di castità… Dei beni dell’anima. Beni questi che vengono offerti totalmente a Dio con l’obbedienza” (S. Th. II-II, 186, 7). I tre voti religiosi sono, dunque, le tre componenti di quell’olocausto, di quell’offerta totale di Sé a Dio che la vita consacrata comporta. Questi sono i frutti che Dio anzitutto cerca, prima ancora che le nostre opere e iniziative.
Un Capitolo Generale è l’occasione per verificare se il Signore Gesù può trovare nei singoli e nella Congregazione il frutto di una vita totalmente offerta a Dio; il frutto di un’obbedienza che non sia solo formale e a parole, mentre di fatto è soppiantata dall’indipendenza che cerca di fare la propria volontà ad ogni costo; il frutto di una castità non sia offuscata dall’edonismo e da comportamenti ambigui; il frutto di una povertà che distacchi effettivamente dai beni materiali, senza usarli per scopi personali più che per l’apostolato, e faccia vivere sobriamente.
* Il vostro Capitolo ha il compito di eleggere un nuovo Superiore Generale. Commentando questa parabola, S. Gregorio Magno afferma: “Che cosa si intende con il contadino se non l’ordine dei prelati? Essi in quanto presiedono la Chiesa, si prendono cura della vigna del Signore” (omelia XXVI, 3). Dunque, chi svolge il servizio dell’autorità deve preoccuparsi che l’albero, cioè i singoli e tutto l’Istituto, dia i suoi frutti.
Come il contadino, il Superiore deve zappare attorno all’albero e mettere il concime. Possiamo vedere in queste due azioni l’immagine di un’autorità che contrasta tutto ciò che è negativo nella vita e nell’attività dei confratelli e delle comunità e alimenta, invece, tutto quello che fa fiorire e fruttificare la vita consacrata. Tornando alla visione di S. Tommaso d’Aquino della vita consacrata come olocausto, un superiore non solo dovrebbe continuamente chiedersi: sto dando veramente tutto a Dio? Egli dovrebbe anche chiedersi: il mio modo di guidarli aiuta i miei confratelli a dare tutto se stessi a Dio?
E questo dovrebbe essere anche il criterio con cui viene individuata la persona a cui affidare il compito di Superiore. Cioè, non qualcuno che lascia correre, che chiude un occhio, che si accontenta di evitare che vi siano grossi problemi, che diventa come il regista di una vita confortevole per ciascuno. Un Superiore deve far crescere tutti nella consacrazione e nella missione dentro la Congregazione. Usando le parole di S. Caterina da Siena, possiamo dire alla futura nuova guida dei Barnabiti: “Pensa che Dio t’abbia fatta ortolano per estirpare il vizio e piantare la virtù. E così ti prego che tu faccia, e non essere negligente a farlo” (Lettera CLXXV).
Nella liturgia ambrosiana vi è una preghiera per la memoria dei Santi Timoteo e Tito in cui si chiede a Dio: “Dona sempre al tuo popolo pastori che inquietino la falsa pace delle coscienze”. Mi sembra che vi sia qui un buon criterio sia per scegliere un Superiore sia per esercitare l’autorità!
- Cosa possiamo allora chiedere durante questa Santa Messa per intercessione della Madonna Nera, accogliendo il messaggio del Vangelo odierno?
Il vostro Capitolo ha questo motto: “La profezia di un nuovo fervore”. Come sapete, il termine “fervore” era molto caro al vostro Fondatore: parlava di un fervore “stabile, divino, vero” e lo considerava uno dei principali frutti dell’agire di Dio in noi: diceva, infatti, che “il fervore buono e santo è fuoco del Padre, splendore del Figlio, fiamma dello Spirito Santo” (Detti notabili, X, 1). E spesso opponeva al fervore il rilassamento, la tiepidezza e la pigrizia, da cui metteva costantemente in guardia i suoi figli spirituali.
Sia proprio questo il dono che chiediamo per tutti i figli di S. Antonio Maria Zaccaria, ma anche per tutti i figli della Chesa: un autentico fervore personale e comunitario, spirituale e apostolico. Esso troverà nell’Eucarestia celebrata, ricevuta e adorata (pensiamo alle 40 Ore!) la sua inesauribile sorgente. E così sia!